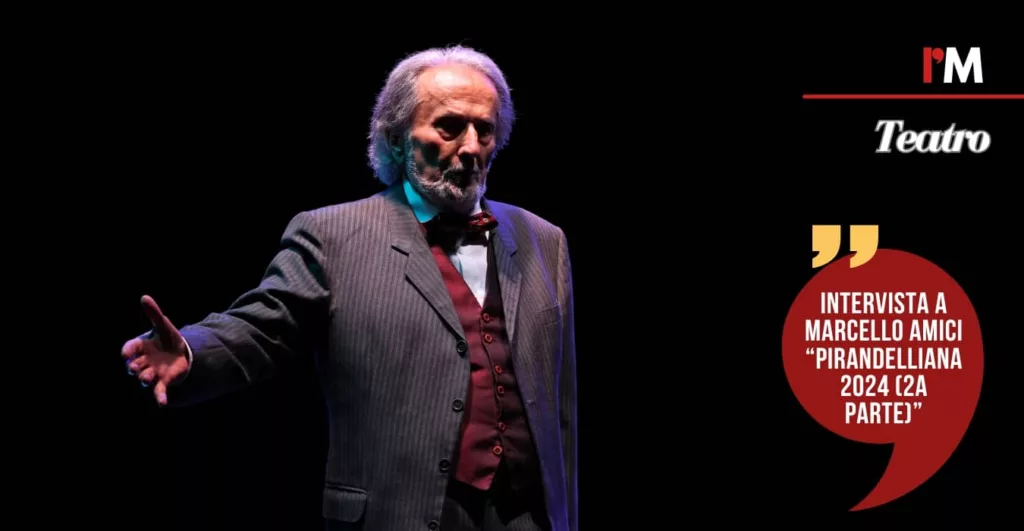Virginia Rifilato intervista il fotografo romano Filippo Trojano –
Guardando i suoi “ritratti di mari” senti l’odore della salsedine. La grana della pellicola ti si attacca addosso, ti accompagna in un vigoroso viaggio interiore, che è il Suo viaggio, ma allo stesso tempo il tuo. Gli occhi di Filippo Trojano sono come i suoi Mari: al pari di un bravo reporter, catturano quegli istanti di vita che diventeranno le immagini di una storia che racconterai ad altri. Ma al contempo, se scavi dentro di te, ti accorgi che quelle immagini riflettono, ancor prima della realtà oggettiva, te stesso, la visione che hai del mondo e il significato che dai alle cose.
Qualcosa che esce da dentro
«Le immagini che creiamo sono qualcosa che esce da dentro di noi. Nel film Professione Reporter di Michelangelo Antonioni, Jack Nicholson intervista lo sciamano e questi gli dice: “Signor Locke, tutte queste domande parlano molto più di lei che di me”. Tanti racconti fotografici in ambito giornalistico, come quelli dei reporter, ci raccontano gli eventi sulla base delle cose che loro stessi hanno dentro. Mi affascina vedere come, nei diversi periodi del mio percorso, ho cambiato le luci delle mie foto, le ombre, il modo in cui ho guardato e fotografato certi dettagli. Attraverso le mie immagini capisco anche come sto io.»
Inizia così la chiacchierata con lui, straordinario e appassionato fotografo. E’ un’afosa giornata estiva rubata a chiacchierare di arte, di valori, di cinema, di vita e anche della nostra città, Roma. Classe ’77, Filippo ha già compiuto un intenso percorso artistico, muovendosi tra i film interpretati come attore per il regista Abbas Kiarostami (Tickets e Copia conforme), la regia di cortometraggi, la scrittura di un libro e l’attività di docente di fotografia che svolge tutt’oggi. E, ovviamente, i suoi originalissimi progetti fotografici, che spaziano dall’intimismo più struggente al realismo magico, saturo di suggestioni ed effetti luministici.

Cos’è cambiato con i passati lockdown dal punto di vista della fruizione dell’arte e della fotografia?
«Cosa sia cambiato forse è ancora presto per dirlo, almeno per me, ma di sicuro durante il lockdown ho potuto vedere delle cose che mi hanno molto affascinato da parte di fotoreporter (anche molto famosi) che hanno rivolto il loro sguardo nell’intimità, addirittura ruotando di 180 gradi l’obiettivo, fotografando e unendo la scrittura a un diario quotidiano fatto di parole e fotografie. Non so quanto siano riusciti a non sentirsi emotivamente in guerra, ma ci hanno comunque mostrato, per la prima volta, le loro facce stanche.
Gli altri che sono stati sul campo hanno continuato a raccontarci, con il cinismo di sempre, i fatti che stavano accadendo, altri ancora hanno provato a sperimentare; vedremo più in là la qualità del risultato. Due lavori che mi hanno tenuto compagnia ed ho molto apprezzato sono stati quelli di Simona Filippini e Valentina Martiradonna: la prima rivolgendo all’interno del teatro famigliare il suo sguardo con delle messe in scena raffinate e intelligenti; l’altra dalla sua finestra e dal terrazzo condominiale, tessendo fili invisibili con il quartiere e realizzando fotografie e video che hanno fatto il giro del mondo. Diciamo che le donne in fotografia oggi le trovo mediamente molto più interessanti di noi uomini, sempre troppo attaccati ai fatti o a fredde elaborazioni concettuali. Mi auguro però che anche grazie a questa esperienza si capisca sempre di più l’importanza che l’arte ha nella nostra vita, perché un rapporto con le immagini ci rende più intelligenti e meno passivi».
Come spieghi il fatto di aver venduto moltissime foto alla fine di quel periodo, nel quale le persone hanno trascorso la maggior parte del tempo chiuse tra le mura delle proprie case?
«Essere stati costretti a restare in casa probabilmente ha portato le persone a volerle rendere più belle, perché quegli spazi che a volte viviamo solo per un passaggio distratto, tra la sveglia e la porta di casa diretti al lavoro, sono diventati invece luoghi diversi, osservati in ogni minimo dettaglio. Penso che tanta della forza che è servita per resistere al lockdown sia arrivata dagli artisti. Se ce l’abbiamo fatta è stato anche grazie alla musica, al cinema e alle immagini in generale.
Quello che gli artisti fanno nella società è linfa vitale e se non sei tu stesso a creare, senti il bisogno di prendere da chi l’arte la fa, e anche questo è un modo estremamente ricco di partecipare, quello di essere il pubblico di un’opera d’arte. Poi quello che succede quando si vende una fotografia o un’opera d’arte in generale è qualcosa di molto delicato e intimo. Per me è una cosa davvero grande.
Pensare che qualcuno ha scelto una mia visione per farla stare nella propria casa, è prezioso. A me piace ragionare insieme alle persone anche su dove una foto possa stare meglio, ma non succede sempre e va bene anche così, sarà la foto a dire dove vuole stare. Poi un’opera è il frutto di un lavoro di squadra che comprende me, i miei stampatori Di Gianni e Barile e dei corniciai artigiani di esperienza e sensibilità. E’ un lavoro corale importante che finisce quando la foto è appesa».

Quali sono le tue foto di maggior successo? C’è un filone prevalente che puoi identificare nei tuoi lavori?
«I Ritratti di mari sono il mio progetto preferito, continuo a venderli da sempre. Forse perché è il progetto in cui mi sono messo più a nudo, in cui mi sono giocato tante cose e, per certi versi, che ho fatto in rapporto anche agli altri, come se fossero dei regali. Ho avuto una sensazione di meraviglia nel guardare quelle visioni. Probabilmente riescono a parlare quelle foto, a dire qualcosa di più degli altri lavori. È un progetto dichiaratamente poetico. Il lavoro sui Cosplay (progetto fotografico che Filippo ha sviluppato nel 2019, pubblicato sulla rivista National Geographic) è più difficile. In queste foto ho ritratto un accadimento, un dramma più evidente che riguarda queste persone che si mascherano. Il progetto è stato realizzato come se fosse un reportage e affinché queste immagini possano entrare nelle case come oggetto d’arte, devono probabilmente cambiare di significato.
Deve aumentare la distanza temporale e cambiare quella affettiva rispetto a quegli eventi, bisogna liberarle. Avendo tenuto i miei corsi su piattaforma durante il lockdown, ho molto riflettuto sull’impatto e il rapporto che abbiamo con le immagini; sempre di più interagiamo con i monitor, guardiamo lì le immagini, le persone. Ma ciò che manca in un monitor, se ci pensiamo, è il profumo, l’odore della pelle dell’altro. Riflettevo di questo aspetto con un medico della Cooperativa Sociale di Psicoterapia Medica con la quale collaboro come docente. E’ bello quando si riesce a fare una foto che ti restituisce un suono, addirittura un odore… è straordinario! Per me una fotografia esiste veramente solo quando viene stampata, lì diventa una cosa reale, la devi toccare».
Quanto sei attaccato affettivamente alle tue immagini?
«Le mie immagini sono parte di me, sono al tempo stesso la mia storia ma anche delle idee, il mio modo di parlare. Se però intendiamo un attaccamento fisico alla stampa, quello non c’è molto. Per me le foto che faccio sono un dialogo con gli altri, devono andare via. In passato c’è stato probabilmente un periodo in cui servivano a me per vedere cose che non riuscivo a capire, oggi è diverso. E finché siamo attaccati alle immagini non permettiamo agli altri di prenderle. Questo è un aspetto complesso del lavoro di un artista, spesso vogliamo che i nostri lavori vengano “capiti”, accettati e comprati, ma al tempo stesso siamo noi stessi a bloccarli senza che ce ne rendiamo conto.
Di sicuro però le opere d’arte hanno bisogno di un loro tempo di maturazione per essere accettate che è un tempo sia di chi le fa che di chi le prende. Però se parliamo della diffusione e della riproducibilità, la fotografia forse è molto più libera della scultura o della pittura, perché le foto sono riproducibili all’infinito. Tanta arte fotografica si imposta sulle tirature limitate che, se ci si pensa, sono un controsenso rispetto all’universalità dell’arte. Come sostengono tanti curatori e direttori di musei scandinavi, la tiratura limitata è una cosa antisociale, addirittura a-civica!
Perché una cosa che si può riprodurre all’infinito deve essere posseduta solo da un’élite e il suo valore dovrebbe essere più alto? Per me non ha senso! Un conto è l’impossibilità di riprodurre due volte la Cappella Sistina, ma dove questo invece non è impossibile il valore delle varie riproduzioni deve essere lo stesso. Di un disco se ne vendono milioni di copie, anche la fotografia deve essere così, alla portata di tutti».
E un tema di ricerca che ti sta appassionando particolarmente, qual è?
«In questo momento lavoro su una linea di confine tra reportage e finzione teatrale, mi piace sconfinare tra le due dimensioni. Sono molto affascinato da quella corrente artistica e letteraria nata alla metà del Novecento, il Realismo magico».
Mi fai pensare ad Alejandro Jodorowsky e ai film di Terrence Malick…
«Sì, mi affascina questa invasione del sogno nel quotidiano, ma senza giungere alla deriva palesemente onirica e mistica dei film di Malick o filosofica di Jodorowsky. Per portare in fotografia questa dimensione credo sia necessario un passaggio fondamentale di pensiero, ossia che la fotografia deve essere una scrittura, un’invenzione anche quando si sta fotografando qualcosa che accade indipendentemente da noi, allora nasce quella dimensione sospesa, appunto, che rende la realtà magica, ma non è la realtà ad esserlo, è un’invenzione (nel frattempo mi mostra la foto che ha scattato pochi giorni prima in un luna park, ndr). Amo il cinema orientale di Kim Ki-duk, ma qui la dimensione non è di sogno: siamo nel nostro mondo, e in questo mondo sta accadendo una cosa illogica. Anche il regista sudamericano Carlos Reygadas mi piace moltissimo.
Nella fotografia questo interesse per il realismo magico mi ha fatto tornare la voglia di ricominciare a lavorare con la pellicola, di ritornare al lavoro dei Mari, che è il più ricco che ho fatto. Negli scorsi anni ho fatto vari lavori reportagistici pubblicati su riviste come Left, Internazionale e National Geographic ed è stato un banco di prova difficile. Proprio perché sono foto che partono dal desiderio di raccontare una storia dal punto di vista giornalistico, è complicato unire questa dimensione a quella dell’arte, la gente non ci vuole stare in questa unione delle due. In Italia infatti la corrente del realismo magico non ha per niente attecchito, l’unico esempio può essere il cinema di Sorrentino, ma è solo una brutta copia di Fellini. E’ un modo vuoto di fare cinema. Edoardo De Angelis invece è un giovane regista che trovo interessante dal punto di vista di questi sconfinamenti.
Da noi probabilmente non ha molto successo perché siamo fortemente realistici, viviamo anche “la maledizione del neorealismo”, ed è molto affascinante provare a capire perché in Italia accada questo fenomeno, ne è un esempio il cinema di Matteo Garrone. Non ce la facciamo a stare nell’onirico, forse dipende anche dalla religione, che ha portato a una rigida codificazione dell’immagine per cui non siamo capaci di passare alla fantasia perché cadiamo in un misticismo. Sono ricerche che mi affascinano».
E alla città di Roma che foto faresti?
«Io sono sempre affascinato dal backstage delle cose, mi piacerebbe riuscire a trovare un modo a per andare “dietro le quinte” di questa città oppure inventare uno sguardo di Roma su noi spettatori. Mi piacerebbe mettere un occhio che riprende all’interno dei monumenti, all’interno della Bocca della verità, della fontana di Trevi. Lo sguardo di Roma su di noi, nelle edicole votive, nei Quattro fiumi di piazza Navona».

E un progetto che ti sta appassionando particolarmente, qual è?
«Quello sullo Stadio del nuoto di Calatrava, rimasto incompiuto. Ho scattato foto lì dall’estate 2019 fino a Natale. E’ un lavoro nel quale ho voluto coinvolgere, attraverso un passaparola, una rete internazionale di illustratori più o meno noti (dalla Corea alla Spagna, dall’Italia all’Iran, al Sudamerica), sono circa trenta. Il mio desiderio è quello di ridare vita, attraverso la fantasia, a un progetto mastodontico rimasto a metà. Ogni illustratore riceve dieci fotografie mie, ne sceglie da una a tre che diventano solo sue, e da quelle inventa una propria storia, una rielaborazione, inserendovi personaggi, acqua, animali, sommergendo tutto, a volte stravolgendo completamente. Ognuno le ha elaborate con il proprio stile. Il lavoro con gli illustratori (Ferraro, Marcolin, Silverini, Terranera tra gli altri) è iniziato a Gennaio 2020 e alcuni di loro sono così appassionati che vi lavorano giorno e notte, mi hanno mandato tantissime e-mail, hanno voluto sapere molte cose sul progetto. Se ci si pensa è una cosa assurda che un luogo così sia oggi in queste condizioni, una cattedrale nel deserto, un buco nero e nessuno lo sa che c’è, nessuno è mai andato a vederlo. Ci siamo molto interrogati con l’amico Alessandro Ferraro sul perché nella storia dell’umanità accadano cose del genere e nel nostro piccolo con le immagini stiamo cercando una nostra risposta.

Mi piacerebbe realizzarne una mostra per i cittadini di Roma, ma un vero sogno sarebbe riuscire a far comprare alla gente quel posto per ridargli la vita che merita, magari tra cinquecento anni succede, se iniziamo a muoverci ora ce la facciamo».