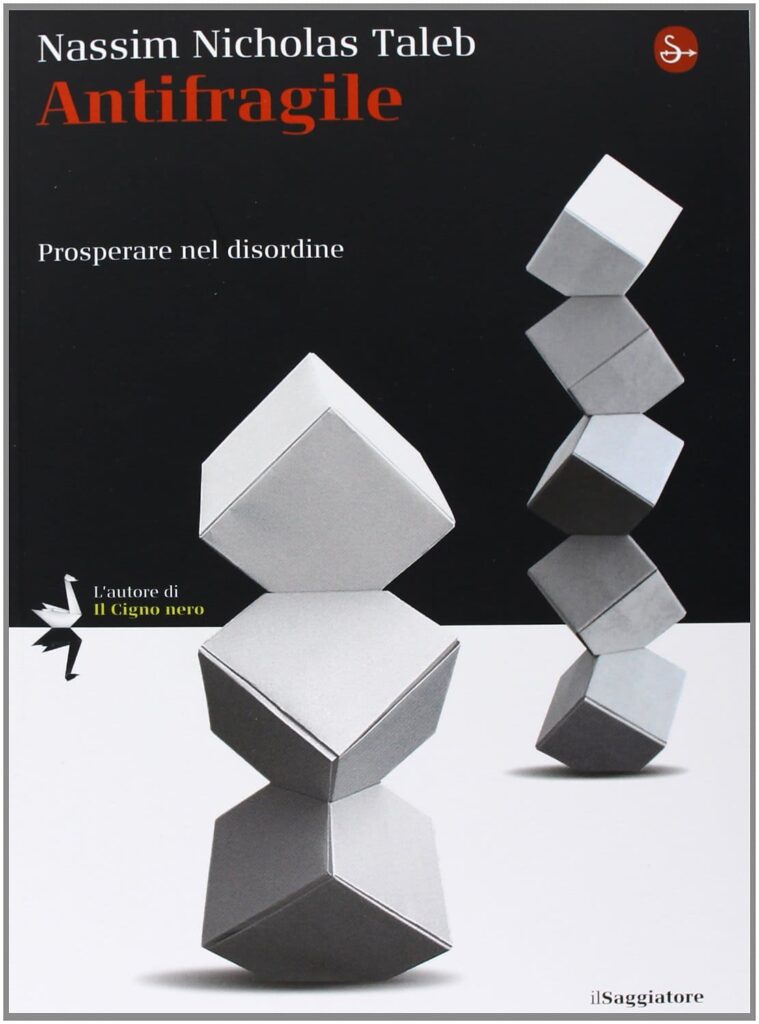La gestione del team, della squadra, è ormai tema affrontato da diverse prospettive e da mille esperti. In questo periodo di studio, matto e disperatissimo, mi è capitato di imbattermi in un libro (Capolavori – Mauro Berruto, ADD editore) che mi ha aperto nuove interessanti prospettive sul tema.
Vecchie convinzioni sulla resilienza

Proprio grazie alla lettura di Capolavori, di Mauro Berruto, ho avuto modo di rivedere alcune convinzioni che mi sembravano assolutamente assodate, se vogliamo addirittura difficilmente scalfibili. Ed in particolare sto parlando del concetto di resilienza.
Negli ultimi decenni si è scritto tantissimo su questo tema e se ne è parlato ancora di più. Resilienti dovevano essere le persone per poter creare team di successo, resilienti dovevano essere le squadre per poter vincere trofei, resilienti dovevamo essere noi per raggiungere i nostri obiettivi nella vita lavorativa (e non solo).
Ma cosa significa “essere resilienti”? Cos’è la resilienza? Si sono scritti trattati sul tema, per cui non si può pretendere di essere esaustivi in poche righe, ma proviamo a dare una visione affrontando il concetto di resilienza nei vari contesti. In ingegneria, la resilienza è la capacità di un materiale di assorbire energia di deformazione elastica in seguito ad urto. In informatica, la resilienza è la capacità di un sistema di adattarsi alle condizioni d’uso e di resistere all’usura in modo da garantire la disponibilità dei servizi erogati.
Cosa dice la scienza
In ecologia e biologia, la resilienza è la capacità di una materia vivente di auto-ripararsi dopo un danno, o quella di una comunità o di un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale, dopo essere stato sottoposto a una perturbazione che ha modificato quello stato. In psicologia, la resilienza è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici. Nel risk management, la resilienza è la capacità intrinseca di un sistema di modificare il proprio funzionamento prima, durante e in seguito ad un cambiamento o ad una perturbazione, in modo da poter continuare le operazioni necessarie sia in condizioni previste che in condizioni impreviste.
In buona sostanza, quindi, una persona resiliente è in grado di resistere alle “intemperie” ritornando allo stato iniziale. I nostri nonni direbbero “come se nulla fosse”.
Circondarsi di persone antifragili
Nel suo libro, però, Berruto affronta un concetto particolare che mi è sembrato molto interessante: dobbiamo creare organizzazioni e circondarci di persone antifragili. Non si parla più di resilienza, che appare un concetto superato, ma di antifragilità.
Questo concetto è stato teorizzato dal filosofo e matematico libanese Nassim Nicholas Taleb in un bellissimo scritto (Antifragile. Prosperare nel disordine. Ed. Il Saggiatore), in cui sostiene che non è più sufficiente essere resilienti, perché è vero che le persone, le organizzazioni, gli sportivi resilienti resistono alle intemperie, le affrontano “a petto in fuori” fino a farsi anche del male e rinascono, come l’Araba Fenice, a nuova vita, in maniera esattamente identica a prima, come se l’ostacolo non li avesse scalfiti minimamente. Si è discusso per anni sulla necessità di essere resilienti, di rinascere ogni volta forti e sicuri dopo ogni sconfitta, dopo ogni ostacolo, dopo ogni problema.
Oggi non è questo quello che si chiede ad un team vincente, sia esso un gruppo di progetto, un’intera azienda, una squadra di calcio o un partito politico. Oggi le organizzazioni vincenti, sono organizzazioni antifragili, ovvero si comportano come l’Idra, figura mitologica che si rafforzava nelle difficoltà: le tagliavi una testa e dal moncherino sanguinante ne nascevano due nuove di teste. L’Idra aveva quindi la grande capacità di trarre forza dalla calamità, dalla difficoltà, dalla sventura.
Un’organizzazione, un team, una squadra antifragile è quindi un gruppo fatto di persone che non demonizzano l’errore, ma che lo valorizzano. Che trovano il modo di identificare l’ostacolo, di analizzarlo e di superarlo e soprattutto dopo (ed è qui che si diventa realmente antifragili e non più solo resilienti) riesce ad imparare da questo imprevisto migliorando le proprie conoscenze, le proprie competenze ed il proprio comportamento.
La cultura dell’errore
Oggi nelle moderne organizzazioni con cui ho avuto modo di lavorare durante la mia quasi ventennale esperienza, che siano esse multinazionali da decine di migliaia di dipendenti in tutto il mondo, o aziende familiari che rappresentano l’eccellenza del food italiano in ogni continente, o start up che rappresentano un business model di eccellenza nel proprio settore, l’errore, l’imprevisto è sempre visto come la peggiore delle disgrazie che possa capitarti.

Non ci si prepara a gestire queste situazioni (che sono molto più comuni dei casi in cui tutto fila liscio ed in maniera perfettamente lineare come da piano) e quindi quando ci si trova davanti all’errore, all’imprevisto non calcolato, la reazione che ho sempre osservato è stata quella classica del riccio: chiudersi in difesa, provare a dimostrare che “non è colpa mia” e che “io ho fatto quello che dovevo fare, per cui ho salvato il mio posto e la mia onorabilità davanti al capo”, fingendosi morto (proprio come fanno molti animali in natura per sfuggire al problema/predatore) fino a quando qualcuno non mi dirà cosa fare per risolvere la questione.
Tutto questo processo che sportivamente possiamo riassumere con l’espressione “difesa ad oltranza”, può anche eventualmente portare al raggiungimento dell’obiettivo iniziale, può portare il progetto alla sua conclusione, magari perché nel team c’è un leader che prende le redini e tira il gruppo fino al traguardo, oppure perché il capo interviene a dirimere la matassa, a trovare la soluzione, ma certamente non fa crescere il gruppo, non ne eleva competenze, status né motivazione.
Il problema non è quindi il risultato, ma il modo in cui si arriva al risultato stesso.
Mi è capitato mille volte di sentire frasi del tipo: “ok, non ci interessa capire, chi è il colpevole, ma piuttosto di trovare una soluzione”. Questo erroneamente potrebbe sembrare un atteggiamento antifragile, ma non lo è. Ho lavorato in gruppi fantastici, di persone in gamba, con enormi competenze, grande voglia di fare e ottimo spirito di gruppo.
Ogni volta che stavamo lavorando ad un progetto e sorgeva un problema si attivavano automaticamente dei processi di reazione e di risoluzione dei problemi fantastici da osservare da parte mia, come project leader. Ero sereno quando lavoravo con loro, perché sapevo che qualsiasi cosa che ci avesse portato fuori dai binari del nostro project plan, sarebbe stata risolta in maniera efficace. Questo era, senza dubbio, il team che avrei voluto avere a fianco per gestire una crisi: pratici, veloci, reattivi e risolutivi.

Col tempo ho capito che questo team non mi avrebbe permesso di portare l’azienda in una nuova era. E questo semplicemente perché non era un team antifragile. Non riusciva ad imparare dagli errori. Gli errori erano sempre e solo ostacoli da superare, in maniera brillante, per carità, ma nulla di più. Al progetto successivo quindi non era difficile che si riproponesse lo stesso identico problema, oppure che si commettessero degli errori incomprensibili, perché erano chiaramente legati a quanto accaduto pochi mesi o addirittura settimane prima.
Non venivano posti in atto in maniera naturale dal team, processi di analisi e di learning dal passato. E c’era sempre una giustificazione esterna, per la serie “ho talmente tante cose da fare che mi è sfuggito”, (la più classica ma anche a mio avviso la più banale e per questo la più odiosa), oppure “ma il mio collega era in ritardo/non mi ha dato quello che mi serviva/ ecc.”, ma anche “ma non era chiaro chi doveva farlo” o peggio ancora “non ci hai detto (o l’azienda non ci ha detto) chiaramente cosa dovevamo fare”.
Ribadisco tutto questo da un team che era tra i più efficienti con cui io abbia mai lavorato nella gestione della crisi.
Allora cosa ci mancava?
Ci mancava l’essere antifragili. Ci mancava la voglia di imparare, di mettere in pratica quello che si era imparato, in buona sostanza mancava la voglia di rischiare!
Abbiamo una dannata paura di rischiare, per cui investiamo il nostro tempo nella gestione. La gestione, che fino agli anni Ottanta/Novanta del secolo scorso, era la carta vincente, oggi non porta da nessuna parte. Oggi “gestire” fa rima con “morire”, se parliamo di business e di aziende. Le aziende, i gruppi, non vanno gestiti. Vanno guidati, vanno stimolati e portati a dare il meglio, a tirare fuori da ognuno le proprie potenzialità. Ad essere persone e player migliori.
Non basta avere in squadra le persone con il miglior CV o con un background di formazione eccellente, se queste non sono team player antifragili.
Ovviamente non è così facile ed immediato fare questo cambiamento. Le organizzazioni aziendali sono macchine complesse fatte di routine, di connessioni tra persone, di storia e di radici. Ma credo non si possa pensare ad un’opzione diversa dal doversi evolvere. Anche le aziende di successo non possono “gestire” questo successo, ma devono inventarselo in continuazione. È la famosa asticella che si alza sempre di più.
Quindi, il primo fondamentale passo, per concludere, è essere consapevoli della nuova dimensione necessaria, l’antifragilità. Parlarne. Porre in essere comportamenti, azioni e fatti che vadano in questa direzione. Ragionare e vivere in maniera antifragile, senza paura di provare e di sbagliare, passando da un logica di “learning by doing” ad una più efficace di “learning by errors”.